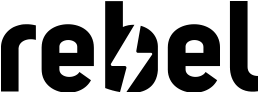Abby Hoffman, la ribellione degli anni Sessanta
La storia di Abby Hoffman – ATTO I
21 ottobre 1967, Washington DC. La lunga vasca della Reflecting Pool era bordata da scuri ciliegi che facevano ombra a settantamila studenti. Altri ne stavano arrivando, canticchiando.
Hey, hey, L.B.J.
How many kids did you kill today?
Intorno al palco un viavai di gente. David Dellinger (il leader del National Mobilization Committee to End the War in Vietnam), Jerry Rubin, il poeta Allen Ginsberg, John Lewis, Phil Ochs (che aveva appena finito il concerto di apertura), Norman Mailer, Robert Lowell, Michael Bowen (l’unico veramente sicuro che stesse per accadere ciò per cui erano venuti), Noam Chomsky, Paul Goodman e ragazzi e ragazze con i capelli corti, le camicie bianche e gli occhiali di celluloide.
Aggrappato al microfono uno che non ti aspettavi: già anziano, in doppio petto.
“Io credo che si stia chiedendo a migliaia di giovani americani di morire per salvare la faccia di Johnson – spiegava – Deve saperlo anche lui che questa guerra non si può vincere, ma non sa come uscirne”.
A parlare il Dr. Benjamin Spock, pediatra. L’autore di Common Sense Book of Baby and Child Care, il libro da cinquanta milioni di copie che aveva ispirato l’educazione di quei genitori i cui figli quel giorno, rispondendo all’appello del National Mobilization Committee to End the War in Vietnam, si erano seduti sul prato del National Mall. Per protestare. Contro la guerra in Vietnam, certo, ma più in generale contro l’autorità svuotata di autorevolezza.
Era la fine degli anni ’60, il decennio delle proteste.
Il decennio del riscatto dei diritti dei neri, delle donne, degli omosessuali, dei poveri, dell’ambiente… Una rivoluzione multicolore che aveva trovato un nuovo punto di caduta nell’antimilitarismo. E da qualche mese anche un nuovo cantore: Abbie Hoffman.
Appoggiato a un tronco, con il mezzo kimono bianco e la fascia colorata in testa, Abbie Hoffman registrava le reazioni dei ragazzi seduti davanti a King Story, lo spettacolo del Bread & Puppet Theater. Dal boccascena di cartone spuntava una caricatura di cartapesta (il re) e dei volti pietrificati che lo salutavano (il popolo).
La voce gridava:
The King had good people.
Good morning, King.
Good morning, King.
Good morning, King.
Il teatro ha un ruolo chiave in questa storia. Abbie era diventato Abbie pochi mesi prima, il 24 agosto del 1967, quando era entrato a Wall Street e aveva fatto piovere banconote da un dollaro sui broker. Quelli si erano messi a ridere e a fischiare e a inseguire il denaro fluttuante, dimenticandosi del flottante.
Ci furono seri danni. Il giorno dopo, venerdì 25 agosto, Wall Street chiuse con 24.97 punti al ribasso. Fu la prima azione di guerrilla theatre, un modo spettacolare di mettere in ridicolo le istituzioni e le persone contro cui si manifestava.
Non un’idea originale di Abbie Hoffman.
Il primo Manifesto di Guerrilla Theater lo ideò Davis, uno dei Diggers, il gruppo di attori-attivisti che Abbie frequentava, nato, guarda caso, a San Francisco. Tutto o quasi nella controcultura nacque a San Francisco, si consolidò a New York e conquistò prima l’America e poi i cuori dei ragazzi europei.
Quando si parla di Abbie Hoffman bisogna tenere sempre a mente questo: la sua è stata una rivoluzione culturale che voleva accendere il cuore della sua generazione per incendiarne la mente e spingere all’azione. Non una rivoluzione violenta.
Più Amleto che Che Guevara, Abbie Hoffman giocava “per far finire in trappola la coscienza del Re”. E per questo avrebbe organizzato per tutta la vita grandiosi spettacoli tragici, convinto che:
“When decorum is [political] repression, the only dignity that free men have is to speak out.”
Per lui, più che per tutti gli altri, erano accorse quel giorno di ottobre le varie ABC, BBC, CBC, NBC e la Canadian Broadcasting Corporate. Per lui e per la promessa che lui, Bowen e Jerry Rubin avevano fatto: far lievitare il Pentagono con la forza psichica di migliaia di manifestanti. Non esattamente il piano che ti aspetti quando parli di terrorismo.
Davanti a una selva di microfoni, Abbie aveva inarcato le sopracciglia e con il fosforo negli occhi e un sorriso furbissimo aveva chiarito il piano della Marcia e dei suoi trentacinquemila irriducibili:
“We will dye the Potomac red, burn the cherry trees, panhandle embassies, attack with water pistols, marbles, bubble gum wrappers, bazookas, girls will run naked and piss on the Pentagon walls, sorcerers swamis, witches, voodoo, warlocks, medicine men and speed freaks will hurl their magic at the faded brown walls, we shall raise the flag of nothingness over the Pentagon and a mighty cheer of liberation will echo through the land.”
Mentre lui parlava, qualcun altro si preparava a reagire.
A poche miglia di distanza dal National Mall, nel corridoio al primo piano del Pentagono, il comandante di compagnia del terzo reggimento di fanteria degli Stati Uniti, Bob Gerson, ripeteva le consegne per l’ultima volta. Sarebbero stati la prima linea di difesa, l’anello esterno a contatto diretto con i manifestanti, integrati con il reparto di polizia militare per coprire le cinquanta yard davanti l’ingresso Nord del Pentagono.
Il loro compito era impedire ad Abbie e ai suoi di avvicinarsi al Pentagono.
Il soldato Sherwood Rudin stringeva il fucile al petto, in fila sull’attenti con i suoi compagni di addestramento del terzo reggimento di fanteria degli Stati Uniti. La Old Guard.
Quelli che novantanove volte su cento facevano il picchetto accanto alle bare dei caduti. Un reparto relativamente sicuro, anche se in casi eccezionali il contratto di ingaggio prevedeva che venissero schierati a difesa delle maggiori Istituzioni del Paese.
Anche per questo l’addestramento era stato particolarmente duro. Isolati in un campo della Virginia per settimane, avevano provato e riprovato i movimenti fino a farli diventare un automatismo: colpire con la baionetta alle mani e alla pancia; colpire alla testa con il calcio del fucile se si trovavano davanti una donna incinta.
Obbedire senza pensare (e far funzionare la macchina) o pensare a quali fossero gli imperativi morali da seguire, eccola la posta in gioco.
“Ci muoviamo tra un’ora e quaranta minuti. Un’ora e qua-ran-ta mi-nu-ti”, scandiva una voce dagli altoparlanti sparsi lungo i tre chilometri del National Mall. Erano le 13:20 circa e un numero imprecisato di persone (cinquantamila? Centomila?) faceva un pic-nic sull’erba sotto ai cartelli dipinti a mano che dichiaravano chi c’era – “Berkeley”, “Harvard”, “Calvin College”- e cosa voleva: “Get Hall Out Vietnam”.
Quando gli elicotteri si alzarono in volo, il rotore delle pale entrò nell’audio dei filmini dei telegiornali che stavano riprendendo la folla di ragazzi, bianchi per lo più. Erano i figli della middle class americana, i lettori di Benjamin Spock. Altri di loro sedevano dall’altro capo del tubo catodico e, guardando quei telegiornali, stavano scoprendo che i nemici dell’America sedevano alle loro tavole.

Un racconto difficile da ricomporre.
Il battaglione di Sherwood Rudin, intanto, aveva raggiunto la linea esterna di difesa del Pentagono. Anche i poliziotti militari erano in posizione, a tre metri l’uno dall’altro. Trecento Marshall attendevano gli eventi calpestando l’erba.
Il sole non ancora tramontato faceva scintillare gli elmetti bianchi mentre i manganelli oscillavano alla cintola.
A quel tempo i manganelli erano fatti dello stesso legno delle mazze da baseball.
David Dellinger, Allen Ginsberg, Jerry Rubin e Abbie Hoffman si erano messi alla testa del corteo di trentacinquemila persone, invadendo l’Arlington Memorial Bridge. Ed Sanders si era schiarito la voce e aveva iniziato a cantare il suo mantra:
“In the name of the amulets of touching, seeing, groping, hearing and loving, we call upon the powers of the cosmos to protect our ceremonies in the name of Zeus, in the name of Anubis, god of the dead, in the name of all those killed because they do not comprehend, in the name of the lives of the soldiers in Vietnam who were killed because of a bad karma”
Dentro il Pentagono cinque o seimila soldati montavano le baionette sui loro fucili e sistemavano gli zaini lungo le pareti. Sherwood Rudin pensava agli amici che aveva ospitato perché erano venuti da New York per manifestare.
Alle 17.00 del 21 ottobre il battaglione di Sherwood Rudin e la compagine di dimostranti si erano ritrovati uno di fronte all’altro, a pochi metri dal Pentagono. L’atmosfera era tesa, nonostante la maggior parte dei ragazzi avesse srotolato le coperte per iniziare il sit-in pacifico e altri stessero infiorando i fucili spianati della Old Guard. Bowen aveva fatto partire il grande rito collettivo; si aspettava di vedere il Pentagono sollevarsi di trecento piedi da un momento all’altro, e con ciò la fine della guerra.
Dal suo megafono Allen Ginsberg guidava il canto tibetano propiziatorio. Le telecamere consumavano chilometri di pellicola.
Walter Cronkite, l’anchorman più famoso d’America al tempo, restò in diretta per tre ore.
Fino alle otto di sera, sotto la luce dei riflettori dei media, non accadde nulla.
Poi scese la notte.
La storia di Abby Hoffman – ATTO II
Trenta minuti dopo le venti, un gruppetto di dimostranti sfondava in solitaria la linea difensiva militare, con una sassaiola seguita da un assalto con armi improvvisate.
All’ingresso del Pentagono, aperte le porte, usciva un fiume di soldati con le baionette spianate. L’epilogo, scontato, macchiava di sangue il prato. La protesta però non diminuì.
Cosa dava coraggio a quei giovani? Cosa non li fece indietreggiare né quella notte né nelle tante battaglie che seguirono in tante città americane?
Per capirlo bisogna riavvolgere il nastro. Al 1964 per esempio, quando uno studente della Berkeley University, Mario Savio, saltando sul tettuccio di una macchina della polizia che aveva tratto in arresto un giovane che distribuiva volantini “politici” fece un discorso memorabile.
Un discorso che è entrato nella storia dell’oratoria americana.
“Il rettore ci ha detto che l’università è una macchina; se è così, allora noi ne saremo solo il prodotto finale, su cui non abbiamo diritto di parola. Saremo clienti — dell’industria, del governo, del sindacato… Ma noi siamo esseri umani! Se tutto è una macchina, ebbene… arriva un momento in cui il funzionamento della macchina diventa così odioso, ti fa stare così male dentro, che non puoi più parteciparvi, neppure passivamente. Non resta che mettere i nostri corpi tra le ruote e gli ingranaggi, sulle leve, sull’apparato, fermare tutto. E far capire a chi sta guidando la macchina, a quelli che ne sono i padroni, che finché non saremo liberi non potremo permettere alla macchina di funzionare”.
Da quel 2 dicembre 1964 i movimenti di protesta erano diventati sempre più forti senza riuscire però a incidere. Il desiderio di “inceppare la macchina” era maturato.
Era diventata una questione urgente. Specie dopo l’annuncio del Presidente Johnson, pochi giorni prima la marcia sul Pentagono, che informava l’America che altri cinquantamila uomini sarebbero stati inviati in Vietnam.
All’annuncio aveva fatto seguito l’arruolamento dei cinquantamila ragazzi spediti a bruciare i villaggi con il Napalm a migliaia di chilometri di distanza, in una guerra che nessuno sentiva giusta o necessaria.
Un arruolamento organizzato come fosse una macabra lotteria in diretta tv: un delegato estraeva da un’urna girevole un bussolotto. Nel bussolotto c’era un foglietto che riportava un intervallo di date. Le date venivano lette e segnate su una lavagna. La telecamera zoomava sulle date. Chi era nato in quell’intervallo di tempo avrebbe ricevuto la cartolina che lo spediva in Vietnam.
Lo show del potere contro lo show dell’impotenza. Ancora una volta una battaglia mediatica. Una battaglia che Abbie era convinto di poter vincere, perdendo. E che spinse migliaia di giovani a mettere “i propri corpi tra le ruote e gli ingranaggi”.
A mezzanotte Sherwood Rudin riceveva l’ordine di avanzare sulla folla.
Chi, come lui, esitava o si rifiutava di obbedire veniva rimandato indietro, sostituito da qualcun altro. Il battaglione calpestava e colpiva chi trovava sulla sua strada. Come una falange romana, la guardia d’onore e i poliziotti militari avanzavano contro ragazzi e ragazze americani avvolti nelle coperte.
L’ingranaggio aveva preso a girare noncurante dei corpi e questo, credeva Abbie Hoffman, avrebbe scosso le coscienze.
La storia di Abby Hoffman – ATTO III
La marcia sul Pentagono fu solo l’inizio; pochi mesi dopo Abby, Jerry, Davide e Ted – il leader della più grande organizzazione studentesca americana, l’SDS – si ritrovarono a Chicago per la convention democratica indetta per eleggere lo sfidante di Nixon.
L’incontro vedeva i partecipanti divisi fin dall’arrivo a causa dell’ostruzionismo dei democratici del Sud, così avversi alle politiche antisegregazioniste da passare di lì a poco nelle file dei Repubblicani.
A questo si sommava il fatto che per una sinistra radicale quale era la New Left, ma anche per la costellazione dei movimenti Yippie, SDS, MOVE e persino per i Black Panters, la candidatura di Hubert H. Humphrey non era accettabile.
Il dolore per la morte di Martin Luther King e Robert Kennedy nell’aprile e giugno di quello stesso anno, e la soppressione violenta subita a Washington e nelle altre città, avevano esacerbato gli animi.
Molti dei diecimila che avevano preso possesso del parco di Chicago nei pressi della Convention erano già pronti a tutto. Ma come dimostrato dai processi successivi fu l’atteggiamento della polizia a far precipitare una manifestazione pacifica in uno scontro sanguinoso.
Prima degli spari, Abbie Hoffman progettava di attenersi al solito canovaccio: una provocazione goliardica, uno scherzo da clown. Jerry e Abbie avevano comprato da un agricoltore del Michigan un maiale di trenta chili scarsi e lo avevano chiamato Pigasus.
Pigasus era stato candidato per correre alle Presidenziali come rappresentante democratico e per lui era stato scritto un discorso di insediamento.
Altri “maiali” – come Abbie e i suoi chiamavano poliziotti e militari – erano intervenuti per sequestrare Pigasus e arrestare i manifestanti per condotta disordinata. Un’accusa di poco conto, per la quale il procuratore di allora non intentò alcuna causa, persuaso da indagini interne del comportamento illegittimo della polizia, a cui si imputavano (molto più che alla presenza di Pigasus) gli scontri dell’agosto 1968.
L’elezione di Nixon, però, cambiò le regole del gioco.
L’amministrazione voleva dare un segnale forte e chiaro della propria volontà di restaurare ordine e legge, e così aprì un processo sproporzionato contro i leader della manifestazione di Chicago, accusati di crimini federali: aver varcato i confini degli Stati per sobillare la folla.
La storia di Abby Hoffman – ATTO IV
Aaron Sorkin ha già raccontato questa storia per Netflix, ma quello che merita di essere sottolineato è l’atteggiamento di Abbie durante il processo. Irriverente, esilarante e così poco accordato alla serietà del momento da potersi considerare un assolo – un monologo da applausi a scena aperta – per il mattatore di una rivoluzione culturale.
L’omonimia tra Abbie e il Giudice Hoffman, che presiedeva il processo, gli ha offerto la possibilità di una serie di scherzi che hanno trasformato il procedimento in una lite padre-figlio. I costumi con cui sono andati “in scena” durante il processo sono altrettanto degni di nota: una toga da giudice, una divisa da poliziotto, una da carcerato…
Complice il comportamento fazioso, dissennato e, forse, connivente del giudice, Abbie è riuscito a irridere l’Istituzione giudiziaria americana.
Certo, a proprie spese.
Il IV atto l’avrebbe visto certamente soccombere se non vi fosse stata la possibilità di ricorrere in appello – due anni di carcere dopo – e qui di vincere.
Dopo il ’70 la vita di Abbie Hoffman è stata costantemente nel mirino dell’FBI che nel ’73 lo arrestò per uso e spaccio di cocaina.
Negli stessi anni si registrava un progressivo scemare della forza di tutti i movimenti studenteschi e la trasformazione dei suoi leader in personaggi dello Showbiz o dell’alta società americana.
Anche Abbie si trasformava, ma per restare fedele a sé stesso.

Attingendo alla miglior tradizione letteraria, Abbie si ripresentava in pubblico “sotto mentite spoglie”. Ancora una volta, pagando il prezzo più alto.
Se i persecutori non erano Rosencratz e Guildersten ma l’FBI, non bastavano un mantello e un naso posticcio per ingannarne il controllo, ma una radicale e reale plastica facciale.
Abbie Hoffman decise così di sottoporsi a un intervento chirurgico e cambiare nome, installandosi nei pressi di New York per continuare il suo impegno a favore delle battaglie civili.
Questa volta nel campo dell’ambientalismo. La sua vita undercovered è proseguita per qualche anno, fino agli anni ’80. In quel lasso di tempo ha scritto due Best Sellers, Steal This Book e Ho Deriso il Potere, e si è ripreso la ribalta nazionale dopo aver pattuito una pena minore con lo Stato.
È comparso in TV e ha rilasciato interviste in cui il volto, trasfigurato, cedeva anche il passo all’età. Lo spirito sempre integro.
Così integro da chiudere il V atto con un suicidio.
“No need to build a stage, it was all around us. Props would be simple and obvious. We would hurl ourselves across the canvas of society like streaks of splattered paint. Highly visual images would become news, and rumor-mongers would rush to spread the excited word… For us, protest as theater came natural. We were already in costume… Once we acknowledged the universe as theater and accepted the war of symbols, the rest was easy. All it took was a little elbow grease, a little hustle.”
La storia di Abby Hoffman fa parte di Rebel Stories. Volume II. Puoi scaricarlo qui.