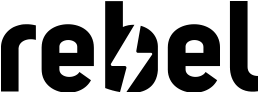Teresa Mattei, la partigiana della porta accanto
Combatteva, Teresa Mattei. Correva e combatteva sempre, nel 1944, tra i vicoli stretti e sinuosi di Firenze. Il fiato corto, il cuore che martellava nel petto, le scarpe consumate che sfioravano i ciottoli sconnessi.
Nella tasca della giacca, strette in un pugno tremante, lettere, parole di incoraggiamento, fugaci istruzioni di combattimento. Messaggi di un tempo sfigurato dal conflitto mondiale, lacerato dalla guerra civile, dentro una più grande guerra mondiale, ma anche accelerato dalla speranza per un avvenire diverso.
Per un futuro di libertà. Per un futuro non più fascista.
La guerra a cui Teresa Mattei aveva deciso di partecipare – la guerra partigiana – non era, e non poteva diventare, una guerra sporca contro un nemico anonimo in uniforme. Una guerra senza morale contro un potere senza volto.
Era altro, ben altro: un impeto contro l’ingiustizia, contro la violenza, contro l’immobilismo. Un salto nella storia.
Di fronte a un’alba antifascista, le strade di Firenze – quelle strade che un tempo avevano accolto i suoi passi lenti di studentessa anticonformista – erano, in quell’anno, un labirinto di insidie e opportunità. Ogni angolo poteva celare un soldato tedesco, una spia, un pericolo mortale. Eppure, la gappista Teresa Mattei non si fermava. Non poteva. E soprattutto, non voleva.
La responsabilità della Resistenza
Aveva solo ventitré anni, Teresa Mattei, quando la sua vita fu stravolta, ma anche dilatata, dal fuoco della rivolta.
Discriminata per aver rifiutato di aderire ai gruppi fascisti e alla legislazione antisemita, Mattei maturò una sua sensibilità politica e poi, nel tempo del conflitto, si gettò anima e corpo nella Resistenza italiana, nel più ampio quadro della Resistenza europea.
Non solo come staffetta, ma anche come una stratega, una combattente brillante che intrecciava reti di comunicazione, organizzava azioni clandestine, distribuiva comunicazioni di matrice antifascista.
Disposta a combattere in un’epoca drammatica. Un’epoca in cui ogni parola, ogni foglio stampato clandestinamente, ogni incontro segreto poteva essere una scintilla capace di incendiare la coscienza delle persone. L’inizio di un ribellione collettiva.
Dentro l’asprezza della rivolta
La guerra, del resto, la colpì direttamente, anche in famiglia.
Suo fratello Gianfranco, esponente di rilievo dei GAP (Gruppo d’Azione Patriottica), venne catturato dai nazisti in seguito a una delazione. La Gestapo lo sottopose a lunghe torture cercando di estorcergli informazioni sui partigiani.
Gianfranco Mattei non cedette, non parlò. Arrivò tuttavia al gesto di togliersi la vita, tragicamente, nel febbraio 1944, venendo poi sepolto nel cimitero a Roma. Per Teresa Mattei, devastata dalla perdita, anche per il lutto improvviso subito dai genitori, fu un durissimo colpo.
Sempre in quel periodo, tornando da Roma per una missione, Mattei subì anche personalmente il peso della guerra. Venne fermata da soldati nazisti, trasferita in carcere a Perugia, insultata, picchiata, vessata, abusata, umiliata.
Un gerarca fascista, impietosito o forse semplicemente convinto della sua innocenza, la salvò quasi per caso quando intervenne per dire: “Una così brava ragazza non può essere una partigiana”.
Non era vero, ma proprio quell’abbaglio – frutto di una cultura politica che non concepiva il dissenso politico delle donne, arrivando fino a farne una caricatura – le diede la libertà. E dunque la possibilità di continuare a combattere, di far valere il fuoco che le bruciava dentro, di partecipare al processo di liberazione.
La combattente partigiana
Nel 1944 la sua città, la sua Firenze, viveva giorni di terrore e di speranza, L’occupazione nazifascista si sgretolava, la
ritirata dei tedeschi era accompagnata da violenza inaudita.
Le formazioni partigiane, e ancora di più i gruppi di cui faceva parte, si muovevano come fantasmi tra i vicoli e le colline, organizzando attentati e sabotaggi e liberando prigionieri. Teresa, nome di battaglia “Chicchi”, pubblicamente impegnata come studentessa della facoltà di filosofia, era una di loro. Una dei GAP.
Faceva anche parte dei Gruppi di Difesa della Donna (GDD) e del Fronte della Gioventù per l’Indipendenza e la Libertà. A Firenze divenne un punto di riferimento per le giovani partigiane. E più tardi, anche a lei e al suo gruppo combattente pare si sia ispirato il regista Roberto Rossellini per un episodio del celebre film Paisà (1946).
La lotta portò Mattei ad avere un ruolo, anche se laterale, non marginale, in uno degli episodi più controversi e complessi della Resistenza: l’attentato al filosofo filofascista Giovanni Gentile. Secondo quanto raccontato più avanti in alcune interviste, fu lei stessa a contribuire al riconoscimento del filosofo presso l’Accademia d’Italia, fornendo ai gappisti indicazioni utili. Fu una decisione drammatica e difficile, senz’altro, ma in quel contesto di guerra assunta con piena consapevolezza.
La liberazione di Firenze
A Firenze, nell’estate del 1944, l’insurrezione era imminente. La città era percorsa da un fremito sotterraneo: i partigiani intensificavano le operazioni contro gli occupanti, le staffette correvano tra le strade con ordini e armi nascoste nei cestini delle biciclette.
Teresa Mattei, figlia di un avvocato antifascista torinese, amico di Carlo e Nello Rosselli – teorici del socialismo liberale, assassinati dal fascismo anni prima –, era dentro tutto questo, con la sua risolutezza, la sua vivacità emotiva e la sua intelligenza strategica.
Quando le forze alleate premevano dal Sud e la ritirata tedesca si faceva feroce, Firenze – futura Medaglia d’oro della Resistenza – si trasformò in un campo di battaglia. I nazisti decisero addirittura di far saltare i ponti sull’Arno per rallentare l’avanzata degli Alleati, lasciando intatto solo Ponte Vecchio, ma disseminando le sponde di mine.
La popolazione soffriva, i rifornimenti scarseggiavano, la violenza era all’ordine del giorno. La città, snodo strategico per i
collegamenti tra Nord e Sud, era presidiata dai nazisti e dai loro alleati della Repubblica Sociale Italiana.
Ogni giorno, gruppi di repressione fascista seminavano terrore. E Teresa Mattei conosceva la più terribile delle verità: essere scoperti significava essere uccisi. “Aver paura, non significava non aver il coraggio di superarla”, spiegò più avanti rievocando quegli intensissimi giorni.
Quando la città insorse, nell’agosto successivo, per decisione del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale (CTLN) e con l’appoggio degli Alleati, la battaglia fu feroce: i partigiani, dopo aver sentito il segnale concordato, i rintocchi della campana di Palazzo Vecchio e quelli della campana del Bargello, si batterono strada per strada, casa per casa. L’incontenibile spinta della libertà, alla fine, prevalse.
Come oggi ricorda una ricerca storica promossa dalla Commissione regionale Pari Opportunità della Regione Toscana, il giurista Piero Calamandrei descrisse così quei giorni:
“Fu una battaglia dentro l’altra: una strategica per Firenze combattuta a distanza, tra le artiglierie alleate schierate a semicerchio sui colli a sud dell’Arno contro quelle tedesche schierate sul semicerchio contrapposto delle colline di Fie- sole; l’altra tattica, dentro Firenze che fu combattuta con armi corte per le vie e per le piazze della città”.
Mattei fece parte di tutto questo, di quel moto rivendicativo che portò alla clamorosa liberazione del centro toscano, e dunque a ciò che per i fascisti appariva allora indicibile, intollerabile: il trionfo aperto della dissidenza.
Dentro la Costituente, per la Repubblica
Anche dopo la Liberazione Teresa Mattei ebbe la precisa coscienza di una lotta in divenire, quando il paese intero doveva ancora risorgere dalle macerie lasciate del fascismo e il bisogno impellente, il primo bisogno, era uno e uno soltanto: ricostruire.
E farlo dando voce alle donne, ai lavoratori e alle lavoratrici, agli studenti e alle studentesse, a tutti coloro che avevano sognato un’Italia diversa; che per una nuova Italia – per un’Italia lontana dai miti militaristi del regime e dalla parole d’odio del fascismo – si erano
battuti, spesso fino alla morte.
Mattei divenne la più giovane deputata dell’Assemblea Costituente, eletta nel 1946, intervenendo per affermare il ruolo delle donne e il principio di uguaglianza, pur senza far parte della commissione incaricata della stesura della Carta.
Non può sorprendere, allora, date queste premesse, se proprio Mattei, tra i politici e le politiche di allora impegnati a scrivere un’altra storia per il paese, diede un contributo non marginale per l’affermazione netta del ruolo delle donne nella nuova Repubblica.
Nella seduta del 18 marzo 1947, intervenendo con rigore e decisione per affermare, davanti alla stragrande maggioranza di colleghi uomini, che un merito della Repubblica era quello di aver riconosciuto il ruolo della donna “nella sua nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti”, una donna “finalmente cittadina della nostra Repubblica”. Citandola per esteso:
“La lotta per la conquista della parità di questi diritti, condotta in questi anni dalle donne italiane, si differenzia nettamente dalle lotte passate, dai movimenti a carattere femminista e a base spiccatamente individualista. Questo in Italia, dal più al meno, tutti lo hanno compreso. Hanno compreso come la nostra esigenza di entrare nella vita nazionale, di entrare in ogni campo di attività che sia fattivo di bene per il nostro Paese, non è l’esigenza di affermare la nostra personalità contrapponendola alla personalità maschile, facendo il solito femminismo che alcuni decenni fa aveva incominciato a muoversi nei vari Paesi d’Europa e del mondo.
Noi non vogliamo che le nostre donne si mascolinizzino, noi non vogliamo che le donne italiane aspirino ad un’assurda identità con l’uomo; vogliamo semplicemente che esse abbiano la possibilità di espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie, tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione democratica del nostro Paese. Per ciò riteniamo che il concetto informatore della lotta che abbiamo condotta per raggiungere la parità dei diritti, debba stare a base della nostra nuova Costituzione, rafforzarla, darle un orientamento sempre più sicuro”.
La politica, dopo la Resistenza
L’ex-partigiana, con questo spirito, continuò a battersi per i diritti delle donne nel corso degli anni, per l’uguaglianza, per un futuro dove nessuno fosse costretto a vivere senza dignità e libertà.
Il suo fu un percorso articolato, ricco, e anche doloroso e contraddittorio, che la portò ad esempio ad essere espulsa dal PCI nel 1955 in dissenso con la dirigenza, ma che comunque non le fece mai venire meno la volontà e il desiderio di tutelare gli ultimi, i fragili, quelli che più facilmente possono essere marginalizzati e più difficilmente hanno la possibilità di farsi sentire – ad esempio i bambini e le bambine di ogni luogo, per cui fondò a Milano un Centro Studi per la progettazione di nuovi servizi e prodotti per l’infanzia.
L’ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel 2005 insignì Teresa Mattei del titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E ancora ultranovantenne a Mattei capitò di dire, in un’intervista: “La cosa più importante della nostra vita è aver scelto la nostra parte”.
Nel 2013 – con una vita alle spalle e una famiglia negli occhi – si spense con la stessa fermezza esibita a vent’anni, ricordata per quel che era stata, celebrata quel che aveva sempre voluto essere: una donna della Resistenza. Un’italiana libera.
La storia di Teresa Mattei fa parte di Rebel Stories. Volume III. Puoi scaricarlo qui.