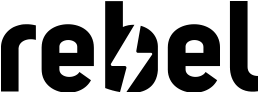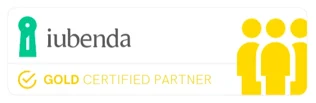BIKO è morto! Black man, you are on your own
Biko è morto e non abbiamo pianto abbastanza la sua morte. Biko è morto e forse è anche colpa nostra. Della nostra indifferenza, del nostro non voler prendere mai una posizione netta. Di pensare e di dire “non è un nostro problema”. Biko è morto, ammazzato in una notte, a soli 30 anni, e mi viene in mente la frase “Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte. Mi cercarono l’anima a forza di botte”.
Questa è la rievocazione della sua vita. L’esempio di un non ribelle, in atto di ribellione, che occupa un posto importante nella Storia proprio per il suo “urlo” alla non violenza, così forte da aver scardinato il pensiero alla base del costituzionalismo dell’Apartheid.
Gli anni della Grande Apartheid
Stephen Bantu Biko nasce il 18 dicembre 1946 a King William’s Town, in Sudafrica, nel cuore di una nazione profondamente segnata dall’Apartheid.
Un sistema di segregazione razziale e di oppressione, imposto dal 1948 al 1994, che costringe i neri sudafricani ad essere prigionieri sulla loro stessa terra. Non è solo una questione politica: è una vera struttura che mira a spaccare e dominare, che infligge una violenza quotidiana e senza tregua su milioni di persone.
Immagina di nascere e vivere in un paese dove non sei considerato umano, ma solo una risorsa economica o, peggio, una minaccia da tenere sotto controllo. Con la tua pelle nera sei condannato automaticamente a una vita di povertà, sfruttamento e umiliazione. Potresti perdere la casa ed essere costretto a vivere lontano dai tuoi familiari, solo perché c’è un governo che lo impone.
I neri infatti sono confinati in “bantustan”, piccole e sovraffollate aree lontane dalle città, senza lavoro né risorse, circondati da posti di blocco, filo spinato e leggi che schiacciano. I bianchi hanno i quartieri, le scuole, gli ospedali, i parchi, i mezzi di trasporto.
Non esiste uguaglianza. Non esiste giustizia, ma solo la paura di poter essere fermati, picchiati, arrestati senza processo. E nei casi peggiori torturati o ammazzati.
Perché l’Apartheid non uccide solo il corpo: uccide la dignità.
Biko e lo Student Representative Council
In questo clima cresce Biko, lontano dai quartieri dei bianchi, in una famiglia Xhosa, e se ci riflettiamo non sembra nemmeno un caso: i Xhosa sono un popolo noto per aver attraversato guerre di frontiera e carestie, un popolo che ha imparato a lottare per la sua dignità, e da questo spirito resiliente sono nati leader straordinari come Biko e Nelson Mandela.
Nel 1963 si iscrive al prestigioso Lovedale Missionary Institute ad Alice grazie a una borsa di studio che gli procura padre Aelred Stubbs, docente del Federal Theological Seminary of Southern Africa, e qui conosce Barney Pityana con cui organizza una prima e incisiva azione di sabotaggio delle lezioni, a causa della quale è espulso dal college.
Ancora una volta grazie all’intervento di padre Stubbs, frequenta il St. Francis College, una scuola cattolica, a Marianhill, non lontano da Durban, e nel 1966 intraprende gli studi di medicina, immatricolandosi presso la UNNE – University of Natal Non–European Section di Durban, dove rimane per tre anni senza, però, conseguire il titolo di laurea.
Fin da giovane mostra una forte coscienza sociale e un animo determinato, che lo porta a unirsi all’organizzazione studentesca dello SRC – Student Representative Council, che lo elegge tra i suoi rappresentanti presso la NUSAS – la National Union of South African Students, in qualità di responsabile in Freedom in Society & International Affairs.
Questa è la sua zona di comfort. Una comunità di studenti che condivide le sue stesse idee di giustizia e libertà, e che dà forma al suo pensiero: liberare la coscienza del popolo nero sudafricano.
“Moriremo inutilmente se il sistema politico diventerà nero e continuerà ad essere esattamente come il loro, a usare la polizia per rompere altre teste per le stesse ragioni per cui ora loro rompono le nostre.”
Inizia nel luglio del 1967, presso il Congresso Nazionale della NUSAS, dove si accorge che agli studenti neri è riservato un trattamento diverso rispetto a quello previsto per quelli bianchi.
Eppure non è una novità per lui. Ma a questo si somma un clima di repressione, instaurato dal governo e dalle forze dell’ordine, che a seguito del Massacro di Sharpeville del 1960 è ogni giorno più soffocante. E con movimenti di liberazione dei neri – ANC e PAC – messi al bando, il 1967 sembra e diventa il momento perfetto per creare un’associazione alternativa al NUSAS, pronta ad adottare nuovi metodi di lotta.
E tutto parte da una parola, black che non designa più solo i neri ma tutte le etnie oggetto di discriminazione: Coloured, Indians, Bantu, Nativi.
Biko diventa leader indiscusso di un gruppo sempre più nutrito di studenti, che iniziano a riunirsi per discutere le idee sulla decolonizzazione, il razzismo e i diritti civili dei neri, incoraggiati da pensatori come Du Bois che scrive “Il costo della libertà è inferiore al prezzo della repressione”.
Nel dicembre del 1968, viene indetta la prima conferenza della SASO – South African Students’ Organization, di cui fanno parte esclusivamente studenti neri. Biko è presidente per l’anno 1969.
Solo un anno, perché sceglie di diventare responsabile delle pubblicazioni dell’organizzazione, realizzando una rubrica mensile dal titolo I write what I like, per la quale firma gli articoli con lo pseudonimo di Frank Talk.
La sua filosofia si espande a macchia d’olio.
Black Consciousness Movement
Nel 1970 fonda il BCM – Black Consciousness Movement, il “movimento per la coscienza nera” con lo scopo di trovare una risposta alla frustrazione degli intellettuali africani, e porta il movimento a essere (senza il supporto dei bianchi) non solo una sfida alla segregazione fisica dell’apartheid, ma un grido per liberare l’anima e la mente di una nazione.
Critica il razzismo istituzionale; sfida il liberalismo di facciata che domina anche le istituzioni che si dichiarano antirazziste. Si getta in un dibattito, senza paura, sulle vittime del colonialismo che comprende il degrado dell’autostima e il complesso di inferiorità inflitto ai neri sudafricani. Lotta contro l’autorità per promuovere e difendere la democrazia al suono di “un uomo, un voto”.
E infine, “provoca”, con la sua ridefinizione di black, una rinascita sociale, culturale e politica del paese, insegnando che “nero” è un’identità inclusiva e positiva e che i neri sudafricani possano apportare cambiamenti significativi nella società attraverso una presa di coscienza, un risveglio della propria autostima e la consapevolezza dell’importanza dell’attivismo.
All’unisono, il movimento incoraggia i giovani ispirandosi a figure come Martin Luther King, contribuisce allo sviluppo della Black Theology e dei movimenti culturali e porta alla formazione di nuove organizzazioni comunitarie e politiche come la Black Peoples’ Convention, un’associazione politica con lo scopo di dar vita a un sistema economico regolato dai valori di uguaglianza e giustizia sociale e a una politica educativa gestita da neri e ad essi esclusivamente rivolta.
Lavora inoltre assiduamente per i BCP – Black Community Programmes, una serie di progetti, riservati e gestiti solo dalla componente nera sudafricana, volti all’acquisizione progressiva della consapevolezza di essere capaci di portare avanti progetti e attività in modo autonomo.
Ogni struttura è quindi concepita per restituire voce e autonomia ai neri sudafricani in un sistema che li vuole passivi e silenti.
Il termine “nero”, in mano a Biko, è un potente strumento di affermazione del diritto alla dignità, alla bellezza nera, alla liberazione.
Nel 1970 afferma “per raggiungere un’azione reale devi essere tu stesso una parte viva dell’Africa e del suo pensiero; devi essere un elemento di quell’energia popolare che è interamente chiamata a liberare il progresso e la felicità dell’Africa”.
Biko non vuole la violenza ma, come riportato da più fonti, cerca “una rivoluzione pacifica e di riconciliazione” che esclude a priori una fase transitoria di rivalsa dei neri contro i bianchi.
Biko e il Black consciousness and the quest for a true humanity
La dichiarazione filosofica più eloquente di Biko è contenuta nel saggio “Black consciousness and the quest for a true humanity”, pubblicato nel 1973, in cui cerca di mettere in relazione le idee di Cone con il Sudafrica, sostenendo che il razzismo nasce dallo sfruttamento economico.
I leader della comunità bianca dovettero creare una sorta di barriera tra bianchi e neri affinché i bianchi potessero godere di privilegi a spese dei neri e sentirsi comunque liberi di fornire una giustificazione morale per l’evidente sfruttamento che urtava perfino la più dura delle coscienze bianche.
Biko rifiuta fermamente l’idea che la soluzione all’Apartheid in Sudafrica possa nascere da un’alleanza superficiale tra bianchi e neri. Per lui, i neri sudafricani devono smettere di cercare la libertà attraverso i bianchi, ma trovarla dentro di sé e nella propria comunità, riconoscendo il potere che hanno per cambiare la società.
Dobbiamo imparare ad accettare che nessun gruppo, per quanto benevolo, può mai consegnare il potere ai vinti su un piatto d’argento. Dobbiamo accettare che i limiti dei tiranni sono prescritti dalla sopportazione di coloro che opprimono.
E ancora:
Black Consciousness è un atteggiamento mentale e uno stile di vita, la chiamata più positiva che sia mai esistita nel mondo nero per molto tempo. La sua essenza è la consapevolezza da parte dell’uomo nero della necessità di unirsi ai suoi fratelli attorno alla causa della loro oppressione, la nerezza della loro pelle, e di operare come un gruppo per liberarsi dalle catene che li legano a una servitù perpetua…
1973. Biko is dead
 Le sue idee e la potenza lirica delle stesse non passano inosservate. E la prima azione di governo, guidata da Balthazar Johannes Vorster, nel 1973, è quella di bandirlo per 5 anni nel distretto natale di King William’s Town, costringendolo di fatto ad abbandonare gli studi alla facoltà di medicina.
Le sue idee e la potenza lirica delle stesse non passano inosservate. E la prima azione di governo, guidata da Balthazar Johannes Vorster, nel 1973, è quella di bandirlo per 5 anni nel distretto natale di King William’s Town, costringendolo di fatto ad abbandonare gli studi alla facoltà di medicina.
Grazie all’aiuto di un giovane prete anglicano, Biko trasforma un vecchio edificio religioso in una sede del BCM e dei BCP e, sebbene sottoposto a dure restrizioni che lo portano a essere costantemente vigilato dalla polizia, continua il suo impegno di guida del Movimento. Le sue idee si radicano nelle coscienze di migliaia di persone, diventando il simbolo di una resistenza che va oltre le barriere visibili dell’apartheid.
Così alla notizia dell’8 settembre 1973 della vittoria del Fronte di Liberazione per il Mozambico (FRELIMO), che innesca un’ondata di entusiasmo in molti stati africani, convinti di poter replicare la stessa esperienza nei loro paesi, Biko organizza una grande manifestazione, Viva Frelimo, il 25 settembre presso il Curries Fountain Football Stadium.
Ma certamente non può passare inosservata. E impunita.
Biko è chiamato a testimoniare, presso la Suprema Corte di Pretoria, al Processo BCP/SASO, a carico di nove leader del BCM per rispondere all’accusa di cospirazione e incitamento all’odio razziale, a seguito della dimostrazione.
Durante il processo, nel 1976, alla domanda dell’avvocato “una volta finita la lotta, qual è l’atteggiamento della SASO?” Biko risponde con fermezza:
“una società aperta, un uomo, un voto, nessun riferimento al colore”.
La libertà non è facile da raggiungere né da ottenere, poiché per viverla pienamente occorre avere accesso a un minimo di beni materiali; senza questi, resta un’idea lontana e astratta. Questa libertà richiede pari opportunità e un impegno concreto a ridurre le disuguaglianze sociali. Non si può parlare di diritto alla felicità se le condizioni per realizzarla vengono continuamente negate. Le persone hanno bisogno di garanzie fondamentali: non patire la fame, avere un tetto, accedere ad acqua pulita e ricevere un’istruzione.
L’intenzione di Biko era chiara:
“non abbiamo alcuna intenzione di vedere i bianchi lasciare questo paese […] intendiamo vederli restare qui fianco a fianco con noi, mantenendo una società in cui tutti contribuiranno proporzionalmente”.
Ma il periodo non è tra i migliori.
La tragedia di Soweto, nel giugno 1976, una delle zone residenziali più popolose del Sudafrica, situata vicino a Johannesburg, in cui rimangono uccise da parte della polizia diverse centinaia di neri, smuove qualcosa, probabilmente paura, e porta moltissime persone ad abbandonare il Paese.
Eppure parliamo di una pacifica manifestazione di studenti neri, che si oppone alla politica scolastica della minoranza bianca, ma che si trasforma in pochi frangenti in una vera e propria carneficina.
Una strage ma che segna, nella sua tragedia, anche la data d’inizio della fine dell’apartheid.
Biko viene arrestato e detenuto presso la stazione di polizia di East London. Rilasciato dopo 101 giorni, la sera del 18 agosto 1977 viene sorpreso in auto a Grahamstowm, in quanto viola le prescrizioni del bando per incontrare altri leader della lotta anti-apartheid, a Città del Capo.
Trasferito in un carcere a Port Elizabeth, è per un mese e sei giorni sottoposto a interrogatori brutali e torture, compreso un pestaggio ininterrotto di 22 ore, probabile causa della lesione al cranio. L’11 settembre è trasferito a Pretoria, costretto a viaggiare per 1100 chilometri nel bagagliaio di una Land Rover. Muore il giorno successivo, il 12 settembre.
L’inchiesta stabilisce che la morte di Biko è dovuta a una lesione cerebrale, ma le circostanze precise della ferita sono ambigue, e nessuno è identificato come responsabile. Alla cerimonia funebre, presieduta dal reverendo Desmond Mpilo Tutu, il suo ricordo viene onorato, ma col dolore (l’ennesimo) di una verità taciuta.
Solo nel 1997, una commissione istituita per volere dello stesso Tutu porta finalmente alla luce i fatti: cinque ex agenti della polizia segreta di Pretoria confessano di aver torturato e ucciso Stephen Bantu Biko.
Oggi, le sue spoglie riposano nel Garden of Remembrance a lui dedicato, vicino a Ginsberg.
La lezione di Stephen Bantu Biko
Penso che Steve si aspettasse di morire per mano della Security Police. Penso che tutti noi ce lo aspettassimo. Ma Steve era pronto a sacrificare la sua vita per la causa dei neri. Sentiva che il suo lavoro era così importante che anche se fosse morto ne sarebbe valsa la pena.
Ntsiki Biko
Un eloquio potentissimo, una superba articolazione delle idee, una penna potente più di una pistola, con cui ha messo in crisi un sistema.
L’artista Paul Stopforth è uno dei primi a reagire criticamente all’omicidio, dando vita alla collezione Biko Series in cui rielabora le fotografie forensi dell’autopsia per rivelare non solo la brutalità inflitta dai suoi assassini, ma anche, e in maniera più lirica, come sia stato involontariamente trasformato l’omicidio in una crocifissione.
La potenza dell’intelletto di Biko e il fatto che lui, a differenza di Mandela, non abbia mai preso le armi contro l’apartheid ci impongono di ricordarlo come il leader carismatico che ha dato la vita per la libertà, sua e degli altri.
Il suo corpo nudo e senza vita ha permesso di far camminare ovunque il processo di riappropriazione di quella “negritudine” che rende i neri sudafricani unici e che è stata per tanto tempo e programmaticamente sfigurata dai bianchi.
Biko è un simbolo di libertà di un popolo (inteso nel senso più ampio del termine, e che comprende tutti quelli che lottano per i propri diritti). Un popolo che continua a marciare per la giustizia.