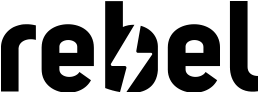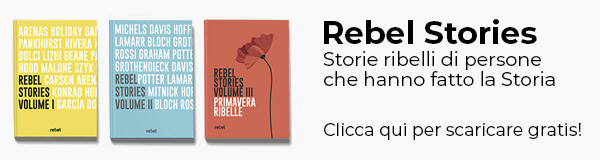Harry Wu, uno squarcio nell’ombra della storia
Raccontare la vita di un uomo che ha passato quasi vent’anni in un campo di lavoro forzato – un luogo in cui le sofferenze fisiche si mescolavano alla brutalità psicologica – non è facile.
Può essere però utile, e talvolta necessario. Può trasmettere un messaggio.
Perché la storia di Harry Wu, del dissidente cinese Harry Wu (Wu Hongda, alla nascita), è quella di una tragedia del XX secolo. È quella del volto oscuro del Novecento.
È la storia di una traiettoria, di una lotta costante contro il silenzio e l’indifferenza per far conoscere al mondo le atrocità dei Laogai, i campi dell’oppressione.
È un grido di denuncia contro il potere – pur parziale, imperfetta e insufficiente – e di una sfida sfacciatamente lanciata alla forza apparente dell’inamovibilità.
Conoscere Harry Wu significa perciò confrontarsi con una realtà cruda, a tratti tetragona alla verità, eppure frutto del Novecento. Del nostro tempo.
Le radici della repressione
Harry Wu nacque l’8 febbraio 1937 a Shanghai, una città che si trovava nel pieno di un cambiamento disordinato, tra inedite accelerazioni e brusche decelerazioni.
Crebbe in un ambiente benestante, di orientamento cattolico, dentro un paese ancora poverissimo – la Cina – in procinto di compiere un salto storico di portata epocale; con tutto ciò che questo avrebbe comportato.
Furono i turbolenti anni a venire, quelli delle scosse portate dalla Seconda guerra mondiale, della guerra civile e della vittoria del Partito comunista di Mao Tse-tung, nel 1949, a segnare un cambiamento radicale nel destino della sua famiglia.
E quindi nel suo percorso di vita, personale e professionale.
Considerata parte integrante dell’irriducibile classe avversaria, e dunque estranea al proletariato e alle sue esigenze, la famiglia di Wu – come quella di molti altri ragazzi e ragazze – finì nel mirino del nuovo governo comunista.
Wu, seppur giovane, scoprì progressivamente quanto stretta potesse diventare la morsa della repressione.
“Durante la mia giovinezza – ricordò più tardi – mio padre perse tutte le sue proprietà. Avevamo problemi economici. Il governo sequestrò tutte le proprietà del paese. Fummo costretti a vendere il mio pianoforte”.
Fu dunque testimone di un’evoluzione radicale e, nell’esserlo, scoprì con una brutale verità: nella nuova Cina le opinioni contrarie a quelle espresse dalla classe dirigente rivoluzionaria – convinta di avere una missione storica di riscatto e progressione – erano poco o nulla tollerate.
Anzi, apertamente osteggiate.
Da studente brillante in geologia all’Università di Pechino, Harry Wu si trovò così a fare i conti con le contraddizioni di un sistema politico e sociale allergico alla dissidenza.
Nel 1960, a 23 anni, fu arrestato con l’accusa di sostenere la “controrivoluzione” per aver osato criticare apertamente il Partito (e per aver messo in discussione la legittimità dell’invasione dell’Ungheria nel 1956 da parte dell’Unione Sovietica, ancora alleata della Cina, allora).
La condanna fu rapida, e sommaria, senza alcun processo; al termine di un procedimento tipico dell’epoca. La pena, terribile: i temuti Laogai.
Ovvero i campi penitenziari della Repubblica Popolare Cinese finalizzati al cosiddetto lavoro correzionale, cioè alla rieducazione e alla professionalizzazione.
Fu l’inizio di un’esperienza mai più dimenticata. Un’esperienza che, oltre a Harry Wu, riguardò segmenti consistenti di generazioni diverse.
Di giovani, di studenti, di professionisti, intellettuali e funzionari accusati di minacciare l’ordine costituito.
Missione sopravvivenza
Il sistema dei Laogai (in cinese “riforma attraverso il lavoro”) non era un semplice strumento di punizione.
Introdotti negli anni Cinquanta (e precisamente nel 1957) su impulso della dirigenza riunita attorno a Mao Tse-tung, presidente della Repubblica popolare nonché segretario del Partito comunista cinese (PCC), l’insieme dei campi fu concepito ufficialmente – pur nel massimo riserbo – con lo scopo di riabilitare i detenuti, soprattutto se di segno politico conservatore, moderato o comunque anticomunista.
Testimonianze, studi e analisi successive hanno però sollevato molte domande sulla reale funzione di questi luoghi, mettendo in evidenza episodi di sfruttamento e di abuso mirati a reprimere il dissenso politico e a massimizzare il lavoro umano, soprattutto nel corso della seconda metà del Novecento, all’epoca della Campagna dei cento fiori, del Grande balzo in avanti, della cosiddetta Rivoluzione culturale.
Le condizioni di vita erano spesso disumane, con prigionieri costretti a impieghi estenuanti, a turni intensissimi con scarsi rifornimenti di cibo, paghe mensili molto esigue e frequenti sopraffazioni.
Per i detenuti, considerati veri e propri nemici dello Stato, umiliazioni e vessazioni erano tutto fuorché imprevisti.
Tutto fuorché incidenti di percorso. E d’altro canto, ciò che veniva prodotto nei campi diventava poi merce sul mercato, rendendo così il sistema dei laogai una fonte di guadagno per lo Stato cinese.
Wu visse uno dei periodi più terribili di una vicenda ancora inesplorata (e sempre ridimensionata, contestualizzata, levigata, o negata dal governo cinese).
Gli anni in cui il mondo non guardava, le nazioni non sapevano, le persone tacevano o erano indotte a tacere – anche in Occidente.
Durante i suoi 19 anni di prigionia, venne trasferito da un campo all’altro, assistendo in prima persona a scene terribili. Nonostante tutto, però, non si piegò.
Se la detenzione segnò ogni aspetto della sua vita, il suo spirito non si spezzò mai.
Il dolore fisico e psicologico, la fame cronica, la violenza divennero parte della sua realtà quotidiana, ma furono anche ciò che gli permisero di trovare dentro di sé la forza per continuare.
Wu visse ogni giorno, per quasi vent’anni, come un sopravvissuto. Ripromettendosi però che, se fosse riuscito a salvarsi, se fosse stato capace di resistere, avrebbe poi raccontato la sua verità; una verità in controtendenza rispetto all’immagine che la nuova Cina comunista intendeva fornire di sé.
Il tempo della denuncia
 Il rilascio di Harry Wu nel 1979, alla fine della Rivoluzione Culturale, segnò l’inizio di una nuova fase della sua esistenza, anche se la sua esperienza nel sistema dei laogai non lo abbandonò mai.
Il rilascio di Harry Wu nel 1979, alla fine della Rivoluzione Culturale, segnò l’inizio di una nuova fase della sua esistenza, anche se la sua esperienza nel sistema dei laogai non lo abbandonò mai.
Ferito psicologicamente, e con la sensazione di aver perso vent’anni della sua giovinezza, Harry Wu decise di fuggire dalla Cina.
Negli Stati Uniti, dove si trasferì nel 1985 grazie a un programma di scambio accademico, iniziò una nuova vita come testimone delle atrocità che aveva subito.
Pur essendo un uomo segnato, e profondamente, era anche determinato a non lasciare che la sua sofferenza rimanesse un segreto.
Nel 1992, Wu fondò la Laogai Research Foundation, un’organizzazione dedicata alla documentazione e alla denuncia del sistema dei Laogai.
Attraverso il suo libro, Laogai: The Chinese Gulag, tentò di rivelare al mondo la brutalità di un sistema di lavoro forzato che nessuno aveva mai veramente compreso.
Il suo lavoro non si limitò alla denuncia, ma puntò a sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sul fatto che i Laogai non fossero una realtà del passato, ma una delle forme persistenti del capillare potere cinese.
Le sue parole provocarono dibattiti, discussioni, iniziative, e poi interventi, interviste, critiche e attacchi personali; pur spingendo molti verso una riflessione meno superficiale sul PCC e spingendo la stessa Cina – sempre più pressata e incalzata dalla comunità internazionale – a mettere in discussione le sue pratiche e le sue prassi discriminatorie.
Al tempo della denuncia, aperto e supportato dalle parole di Harry Wu, seguì infatti – tra conflitti e contraddizioni, ombre e opacità – anche il tempo del rinnovamento; con il regime cinese costretto a rimodulare l’uso dei campi, ad accantonare progressivamente approcci fortemente in contrasto con il rispetto dei diritti umani.
Coraggio, senza compromessi
Nonostante i rischi, Harry Wu non si limitò a restare lontano dalla Cina.
Nel 1995, tornò sotto falsa identità per raccogliere prove dirette sugli abusi e le atrocità che si stavano verificando nei laogai.
Purtroppo, il suo coraggio lo portò di nuovo in conflitto con il regime: arrestato con l’accusa di spionaggio, fu condannato a 15 anni di prigione.
Questo episodio suscitò un’enorme ondata di proteste internazionali, con organizzazioni per i diritti umani e il governo statunitense che chiesero il suo rilascio. Dopo 66 giorni di prigionia, grazie alla pressione globale, Wu fu liberato.
Questo episodio non fece che rafforzare la sua determinazione.
Durante la sua detenzione, infatti, continuò a ricevere supporto da ogni angolo del mondo, a dimostrazione del fatto che la sua battaglia aveva ormai raggiunto una dimensione internazionale.
Wu continuò a lottare contro lo sfruttamento dei prigionieri nei Laogai, diventando un interlocutore delle istituzioni internazionali e chiedendo azioni concrete.
Divenne dunque il volto di una battaglia senza compromessi per i diritti umani. Un faro acceso per milioni di prigionieri, invisibili e dimenticati, nella notte della storia.
Nel 2006, dopo vari pronunciamenti arrivati dagli USA, e dopo diversi condanne da parte dei parlamenti nazionali (come in Germania, Italia o Australia), anche una risoluzione non legislativa del parlamento dell’Unione Europea, concernente le relazioni con Cina, condannò “l’esistenza dei campi di lavoro Laogai sparsi nel paese, nei quali la Repubblica Popolare Cinese detiene attivisti favorevoli alla democrazia e ai sindacati e membri di minoranze senza un giusto processo, costringendoli a lavorare in terribili condizioni e senza cure mediche”.
Ancora nel 2009, sulla base dei dati raccolti e diffusi dalle Nazioni Unite (e nello specifico dall’UNHCR), circa 190.000 cinesi, nel quadro di oltre 300 centri dislocati nell’immenso territorio della Cina, stavano scontando una pena “laojiao”.
Tuttavia la volontà di procedere con riforme strutturali, e dare inizio al rinnovamento, cominciò ad agevolare, o accelerare, lo smantellamento del sistema concentrazionario costruito nel Novecento.
Un processo che deve ancora concludersi, sotto gli occhi vigili del mondo.
Nel frattempo, Harry Wu morì.
Scomparve nel 2016 in Honduras, ma la sua eredità – quella no – non svanì affatto.
“La sua battaglia ha avuto un impatto enorme, non solo su coloro che hanno subito simili atrocità, ma anche su chi oggi riflette sul rapporto tra diritti umani e potere politico”, scrisse il New York Times nel ricordarlo.